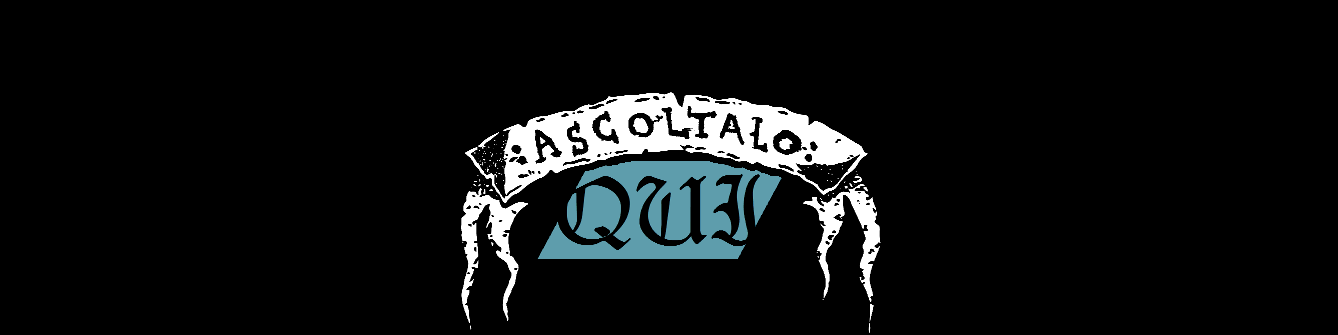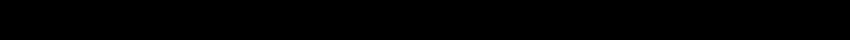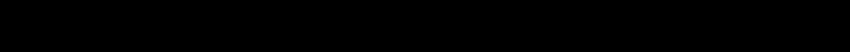I mondi di sopra e di sotto si fondono in una cosa sola, unica ed inscindibile benché dotata delle miracolose differenze di entrambi, giunti al terzo appuntamento con il meglio che striscia fuori dalle crepe dell’anno in corso d’opera per la redazione. Chi meglio degli Enslaved può ottenere un simile risultato? Probabilmente nessuno, ma non è una novità bensì qualcosa che ormai sappiamo e diamo anche troppo spesso per assodato -o scontato, colpevolmente- da moltissimi anni a questa parte: la novità resta infatti comunque illesa ed illibata, nonché in un certo senso sempre più grande, in tutto ciò che di volta in volta creano in studio di registrazione i cinque norvegesi, celebrati maestri del cambiamento e della trasformazione giunti nuovamente sugli scaffali con il nostro personale disco di marzo, ovvero l’“Heimdal” uscito il terzo giorno del terzo mese come ormai da tradizione per il colosso discografico Nuclear Blast Records, con grande sorpresa di chi (molto spesso a ragion veduta) ritiene che l’arte non possa essere creata sotto major.
Il secondo episodio del gruppo di Ivar Bjørnson e Grutle Kjellson più Arve Isdal ad uscire con l’attuale formazione, completata da Iver Sandøy alla batteria e Håkon Vinje alle tastiere (quest’ultimo al battesimo di fuoco e ghiaccio con il gruppo già nel 2017, dentro i solchi dell’ormai terzultimo uscito “E”), rispecchia con le sue mille voci e storie in una la coralità che ci teniamo contraddistingua sempre gli articoli della serie sul meglio del mese che puntualmente escono su queste pagine; quello che state leggendo non escluso. Preparatevi dunque a trovare grandissima diversità, emotiva quanto stilistica, nemmeno a dirlo, in ciò che segue – partendo dallo splendido “Inter” dei novizi Fagus che se solo non fosse stato per quei ficcanaso degli Enslaved sarebbe senza dubbio eletto all’unanimità primo disco del mese di gran parte dei mesi possibili e immaginabili. Lo tallonano ad ogni modo altri due album che, in base ai gusti e alle individuali inclinazioni, possono dare del buon filo da torcere ai primi due a loro volta: un altro debutto ma con pedigree (un po’ come gli Høstsol a gennaio, benché con le debite distanze stilistiche e qualitative del caso) e per concludere in bellezza un ritorno dalle virtù davvero inaspettate…

![]() “Non c’è limite alla creatività degli Enslaved: non esiste limite alle potenzialità espressive del duo compositivo Bjørnson–Kjellson, chiunque includa la restante parte dei sempre capacissimi musicisti che li accompagnano – che sia da decadi o da pochi anni, evidentemente la differenza è esigua. Perché “Heimdal” è un disco di conferme strutturali, innovazioni stilistiche continue e coraggio nell’affrontare ogni direzione al pari; ma anche d’identità, che si traduce nel retaggio culturale con sempre più intelligenza abbracciato dal gruppo nella riscoperta continua di sé, così come nella musica che compone – sempre veramenre nuova, sempre dritta al punto anche quando sembra girare su sé stessa in cerca di un porto esclusivamente distante a cui attraccare. Sempre grandiosa nella sua profonda sperimentalità e sempre grandiosa nel suo storytelling, il quale meno che mai va raccontato bensì ascoltato e vissuto. E che siate dunque più avvezzi allo stile di un “Riitiir”, di “In Times” o piuttosto del nuovo corso e del nuovo colpo da maestri appena donatoci da menti artisticamente superiori, è impossibile non lasciarsi trasportare dalla costante ricerca che ha portato i nostri al disco completo numero sedici con la freschezza del primo o del secondo, ma con la maturità del quarantesimo.”
“Non c’è limite alla creatività degli Enslaved: non esiste limite alle potenzialità espressive del duo compositivo Bjørnson–Kjellson, chiunque includa la restante parte dei sempre capacissimi musicisti che li accompagnano – che sia da decadi o da pochi anni, evidentemente la differenza è esigua. Perché “Heimdal” è un disco di conferme strutturali, innovazioni stilistiche continue e coraggio nell’affrontare ogni direzione al pari; ma anche d’identità, che si traduce nel retaggio culturale con sempre più intelligenza abbracciato dal gruppo nella riscoperta continua di sé, così come nella musica che compone – sempre veramenre nuova, sempre dritta al punto anche quando sembra girare su sé stessa in cerca di un porto esclusivamente distante a cui attraccare. Sempre grandiosa nella sua profonda sperimentalità e sempre grandiosa nel suo storytelling, il quale meno che mai va raccontato bensì ascoltato e vissuto. E che siate dunque più avvezzi allo stile di un “Riitiir”, di “In Times” o piuttosto del nuovo corso e del nuovo colpo da maestri appena donatoci da menti artisticamente superiori, è impossibile non lasciarsi trasportare dalla costante ricerca che ha portato i nostri al disco completo numero sedici con la freschezza del primo o del secondo, ma con la maturità del quarantesimo.”
![]() “Se meno di tre anni fa “Utgard” metteva in mostra come nessun’altra uscita del gruppo tutto il plateau di influenze che gli Enslaved hanno raccolto nella loro imponente carriera, giocando su brani unici e sfaccettati saggiamente incastrati fra loro, “Heimdal” si presenta come un fluire in parte più coerente e circoscritto di quegli sprazzi infinitamente progressivi: un viaggio coeso ed emozionante fin dal primo ascolto, in cui gli ottoni risuonano brillanti sui riflessi dello specchio d’acqua e tonanti come solo il suono del corno del figlio di Odino, rimbalzando in fanfare scure che perturbano le linee principali creando giochi di continua complementarietà melodica. Se gli strumenti e gli elementi in gioco sono gli stessi che caratterizzano la formazione da qualche uscita a questa parte, la bellezza dei sette pezzi della nuova opera risiede infatti nel sempre rinnovato modo d’intendere la composizione, palesato nella splendida “Congelia” ma che si ripresenta con intelligenza per tutta la tracklist, in cui più linee di sonorità differenti si incastrano e si rincorrono donando sfaccettature nuove ed incastri che ad ogni ascolto rinascono e mutano: “Heimdal” è insomma, ancora una volta, una storia da ascoltare avidamente – nuova esplorazione da ammirare, un mare in tempesta in cui entrare senza esitazione.”
“Se meno di tre anni fa “Utgard” metteva in mostra come nessun’altra uscita del gruppo tutto il plateau di influenze che gli Enslaved hanno raccolto nella loro imponente carriera, giocando su brani unici e sfaccettati saggiamente incastrati fra loro, “Heimdal” si presenta come un fluire in parte più coerente e circoscritto di quegli sprazzi infinitamente progressivi: un viaggio coeso ed emozionante fin dal primo ascolto, in cui gli ottoni risuonano brillanti sui riflessi dello specchio d’acqua e tonanti come solo il suono del corno del figlio di Odino, rimbalzando in fanfare scure che perturbano le linee principali creando giochi di continua complementarietà melodica. Se gli strumenti e gli elementi in gioco sono gli stessi che caratterizzano la formazione da qualche uscita a questa parte, la bellezza dei sette pezzi della nuova opera risiede infatti nel sempre rinnovato modo d’intendere la composizione, palesato nella splendida “Congelia” ma che si ripresenta con intelligenza per tutta la tracklist, in cui più linee di sonorità differenti si incastrano e si rincorrono donando sfaccettature nuove ed incastri che ad ogni ascolto rinascono e mutano: “Heimdal” è insomma, ancora una volta, una storia da ascoltare avidamente – nuova esplorazione da ammirare, un mare in tempesta in cui entrare senza esitazione.”
![]() “Rapido dietro-front stilistico per gli Enslaved che nel loro percorso evolutivo abbandonano alcune delle grandi follie presenti in “Utgard” andandole a maturare ulteriormente e mitigare in un prodotto, il nuovissimo “Heimdal”, sicuramente sempre sperimentale e progressivo ma anche legato a sonorità più rocciose ed estreme del suo immediato predecessore. L’unica cosa che è rimasta invariata, nella perenne mutazione del gruppo, è dunque la qualità: il cinque norvegesi trasudano perizia, audacia e professionalità da ogni nota e il risultato non può che essere eccellente. Quasi sicuramente starò ripetendo alcuni miei commenti passati riguardanti gli Enslaved, dicendo che la cosa che continua più a sorprendermi disco dopo disco è il modo in cui questa band riesce a mantenere sempre la propria spropositata identità, la propria immediata riconoscibilità e soprattutto, ad ogni cambio, un’efficacia impareggiabile in fase compositiva. Ma finché ci si ripete dicendo cose simili, non c’è davvero motivo di lamentarsi...”
“Rapido dietro-front stilistico per gli Enslaved che nel loro percorso evolutivo abbandonano alcune delle grandi follie presenti in “Utgard” andandole a maturare ulteriormente e mitigare in un prodotto, il nuovissimo “Heimdal”, sicuramente sempre sperimentale e progressivo ma anche legato a sonorità più rocciose ed estreme del suo immediato predecessore. L’unica cosa che è rimasta invariata, nella perenne mutazione del gruppo, è dunque la qualità: il cinque norvegesi trasudano perizia, audacia e professionalità da ogni nota e il risultato non può che essere eccellente. Quasi sicuramente starò ripetendo alcuni miei commenti passati riguardanti gli Enslaved, dicendo che la cosa che continua più a sorprendermi disco dopo disco è il modo in cui questa band riesce a mantenere sempre la propria spropositata identità, la propria immediata riconoscibilità e soprattutto, ad ogni cambio, un’efficacia impareggiabile in fase compositiva. Ma finché ci si ripete dicendo cose simili, non c’è davvero motivo di lamentarsi...”


 Un disco di debutto che, anche solo per il fatto di esserci piaciuto quasi quanto quello degli Enslaved (ad Ordog persino di più!), dovrebbe dirvi qualcosa. Questo qualcosa, nella fattispecie, è “Inter” (Silent Future Recordings) dei Fagus: quartetto di ottime speranze che ci delizia con la sua prima uscita dopo il già interessante EP “Urgewalt” (2013). Dieci anni passano e molto cambia: ma le idee restano chiarissime ed il talento, come sempre, innato.
Un disco di debutto che, anche solo per il fatto di esserci piaciuto quasi quanto quello degli Enslaved (ad Ordog persino di più!), dovrebbe dirvi qualcosa. Questo qualcosa, nella fattispecie, è “Inter” (Silent Future Recordings) dei Fagus: quartetto di ottime speranze che ci delizia con la sua prima uscita dopo il già interessante EP “Urgewalt” (2013). Dieci anni passano e molto cambia: ma le idee restano chiarissime ed il talento, come sempre, innato.
![]() “A tratti straziante, di una bellezza commovente e ricolmo di melodie strabilianti da scoppiare come un fiume di lacrime pronte ad essere versate, che corrono verso la valle dello stoicismo più perentorio, il primo capitolo principale nel viaggio dei Fagus è qualcosa che si percepisce essere importanza fin dalla sua lunga genesi: ricercato, sofisticato nella sua inafferrabile semplicità espressiva. Potente, per come questi brani quasi scarni sono in verità pieni di un’atmosfera che suona gelida in termini ma si sente calda come fosse casa; intelligentissimo, per come la brevità inusuale nel sottogenere più solitamente dilatato del Metal sia l’arma splendida nella faretra di “Inter” (“Zerfall Des Lichts”) prima di piazzare viaggi autoconclusivi come nelle più lunghe “Et In Arcadia Ego” e “Tyche”, che dimostrano una classe già strabiliante. Così il debutto dei Fagus scorre come scorre il vento sulle gote arrossate del viaggiatore che non ha bisogno di andar lontano né di uscire dal suo megacosmo interiore per ritrovarsi: scorre – e scorre lasciando sempre il segno.”
“A tratti straziante, di una bellezza commovente e ricolmo di melodie strabilianti da scoppiare come un fiume di lacrime pronte ad essere versate, che corrono verso la valle dello stoicismo più perentorio, il primo capitolo principale nel viaggio dei Fagus è qualcosa che si percepisce essere importanza fin dalla sua lunga genesi: ricercato, sofisticato nella sua inafferrabile semplicità espressiva. Potente, per come questi brani quasi scarni sono in verità pieni di un’atmosfera che suona gelida in termini ma si sente calda come fosse casa; intelligentissimo, per come la brevità inusuale nel sottogenere più solitamente dilatato del Metal sia l’arma splendida nella faretra di “Inter” (“Zerfall Des Lichts”) prima di piazzare viaggi autoconclusivi come nelle più lunghe “Et In Arcadia Ego” e “Tyche”, che dimostrano una classe già strabiliante. Così il debutto dei Fagus scorre come scorre il vento sulle gote arrossate del viaggiatore che non ha bisogno di andar lontano né di uscire dal suo megacosmo interiore per ritrovarsi: scorre – e scorre lasciando sempre il segno.”
![]() “Nei flussi più malinconici, neri e silenziosi del Black Metal tedesco, lì tra le atmosfere plumbee dei Tardigrada, il chitarrismo torrenziale dei Der Weg Einer Freiheit e l’elegante gusto melodico proprio di una paganità autoctona in decennale evoluzione, prende vita il neonato ma già interessantissimo progetto Fagus. Fra brani che partendo da pochissime note evolvono in grandi spostamenti elettrostatici e arrangiamenti sotterranei che plasmano e distorcono le luci come le ombre delle composizioni, “Inter” cattura e ammalia con i riverberi cangianti di un bagliore intrappolato fra i cristalli del più remoto anfratto. Rielaborando e interpretato dei riferimenti solidi, ma sfruttando con altrettanta classe un layering sfaccettato dal suono dilatato ma tagliente, i tedeschi si presentano con un debutto prezioso e dalla grande immersività: uno che fa presagire un futuro dei più promettenti.”
“Nei flussi più malinconici, neri e silenziosi del Black Metal tedesco, lì tra le atmosfere plumbee dei Tardigrada, il chitarrismo torrenziale dei Der Weg Einer Freiheit e l’elegante gusto melodico proprio di una paganità autoctona in decennale evoluzione, prende vita il neonato ma già interessantissimo progetto Fagus. Fra brani che partendo da pochissime note evolvono in grandi spostamenti elettrostatici e arrangiamenti sotterranei che plasmano e distorcono le luci come le ombre delle composizioni, “Inter” cattura e ammalia con i riverberi cangianti di un bagliore intrappolato fra i cristalli del più remoto anfratto. Rielaborando e interpretato dei riferimenti solidi, ma sfruttando con altrettanta classe un layering sfaccettato dal suono dilatato ma tagliente, i tedeschi si presentano con un debutto prezioso e dalla grande immersività: uno che fa presagire un futuro dei più promettenti.”
![]() “Primo disco ufficiale per i tedeschi Fagus che fa prosegire il magnifico trend di un 2023 carico di debutti estremamente interessanti quando non direttamente sorprendenti, e in generale di grande qualità. Se volessimo comparare questa band con realtà già presenti e più conosciute da anni, si potrebbe facilmente associarli alle produzioni dei Tardigrada: ovvero un Black Metal fortemente atmosferico pur senza dilungarsi, che sfrutta quindi molto bene il suo comparto melodico ed emozionale con composizioni ottimamente pensate e strutturate per funzionare sia quando c’è da aggredire in velocità, sia quando c’è da creare atmosfere etereee e sognanti. A perfezionare il tutto ci pensa un cantato in scream dai toni piuttosto alti, di tradizione tedesca, che taglia come un rasoio e perfettamente l’a tratti impalpabile componente musicale rendendo il tutto ancora più drammatico, avvolgente e teatrale.”
“Primo disco ufficiale per i tedeschi Fagus che fa prosegire il magnifico trend di un 2023 carico di debutti estremamente interessanti quando non direttamente sorprendenti, e in generale di grande qualità. Se volessimo comparare questa band con realtà già presenti e più conosciute da anni, si potrebbe facilmente associarli alle produzioni dei Tardigrada: ovvero un Black Metal fortemente atmosferico pur senza dilungarsi, che sfrutta quindi molto bene il suo comparto melodico ed emozionale con composizioni ottimamente pensate e strutturate per funzionare sia quando c’è da aggredire in velocità, sia quando c’è da creare atmosfere etereee e sognanti. A perfezionare il tutto ci pensa un cantato in scream dai toni piuttosto alti, di tradizione tedesca, che taglia come un rasoio e perfettamente l’a tratti impalpabile componente musicale rendendo il tutto ancora più drammatico, avvolgente e teatrale.”
![]() “Accanto alle sfuriate orgogliosamente ignoranti griffate Folter o Purity Through Fire che da queste parti sembrano piacere purtroppo o per fortuna soltanto al sottoscritto, ogni tanto l’iperproduttiva Germania è in grado di proporre pure qualcosa di leggermente più raffinato, pensato per donare alle sanguigne impalcature teutoniche un tocco di atmosfere fiabesche, il quale, nelle giuste mani, si fa apprezzare con ragione un po’ da chiunque. Miscelando un poco di Tardigrada (soprattutto di “Vom Bruch Bis Zur Freiheit”), un qualcosa di Dauþuz e soprattutto del gran senso armonico per degli esordienti, i Fagus lavorano di fino e centrano senza problemi la fatidica prima prova su formato esteso, senza prendersi rischi che sarebbero anzi inutili quando ciò che ti riesce meglio è tirare fuori solenni melodie sui tempi medi. Per gli esperimenti, magari nell’ambito delle vocals invero lasciate abbastanza a se stesse, ci sarà tempo in abbondanza negli anni a venire, mentre questi quaranta minuti di sublime tempesta sulle infide cime innevate dell’Europa continentale faremmo meglio a goderceli tutti al più presto.”
“Accanto alle sfuriate orgogliosamente ignoranti griffate Folter o Purity Through Fire che da queste parti sembrano piacere purtroppo o per fortuna soltanto al sottoscritto, ogni tanto l’iperproduttiva Germania è in grado di proporre pure qualcosa di leggermente più raffinato, pensato per donare alle sanguigne impalcature teutoniche un tocco di atmosfere fiabesche, il quale, nelle giuste mani, si fa apprezzare con ragione un po’ da chiunque. Miscelando un poco di Tardigrada (soprattutto di “Vom Bruch Bis Zur Freiheit”), un qualcosa di Dauþuz e soprattutto del gran senso armonico per degli esordienti, i Fagus lavorano di fino e centrano senza problemi la fatidica prima prova su formato esteso, senza prendersi rischi che sarebbero anzi inutili quando ciò che ti riesce meglio è tirare fuori solenni melodie sui tempi medi. Per gli esperimenti, magari nell’ambito delle vocals invero lasciate abbastanza a se stesse, ci sarà tempo in abbondanza negli anni a venire, mentre questi quaranta minuti di sublime tempesta sulle infide cime innevate dell’Europa continentale faremmo meglio a goderceli tutti al più presto.”
 Il pedigree promessovi è quello dei Verminous Serpent con dentro niente meno che il nostro Nemtheanga preferito (nessun bisogno di CV allegato), le sei corde degli Slidhr e le pelli dei Malthusian se non fosse che dei Malthusian i Verminous Serpent hanno il chitarrista, ma alla batteria. Confusione? Molta – e nel senso migliore del termine. Casino? A volontà: anch’esso un debutto (uscito per Amor Fati Productions), anch’esso di sostanza – come da comprensibile previsione.
Il pedigree promessovi è quello dei Verminous Serpent con dentro niente meno che il nostro Nemtheanga preferito (nessun bisogno di CV allegato), le sei corde degli Slidhr e le pelli dei Malthusian se non fosse che dei Malthusian i Verminous Serpent hanno il chitarrista, ma alla batteria. Confusione? Molta – e nel senso migliore del termine. Casino? A volontà: anch’esso un debutto (uscito per Amor Fati Productions), anch’esso di sostanza – come da comprensibile previsione.
![]() “L’Irlanda che pesta e che pesta alla grande trova ben più di uno sfogo o di un divertissement in “The Malign Covenant”, titolo azzeccatissimo per una prima prova in studio programmatica di un mo(n)do intero di intendere la materia Black Metal: sulfurea, caliginosa, occulta e spietatamente oscurantista. Non c’è salvezza qui – ma i tre irlandesi ci sorprendono con qualcosa che non è il punto d’incontro dei rispettivi progetti, né una variazione sul tema dell’abbandonato one-off Blood Revolt di oltre dieci anni or sono. Alan non canta da Alan, Matt Bree suona più primitivo, ossessivo e al medesimo tempo ipnotico possibile, e l’ex-Myrkr Joseph Deegan trova una nuova via per esprimere il bisogno di oscurità che non sia costantemente inerpicato sulle dissonanze. Il risultato è stregonesco, pestilenziale e mefitico. Forse monotono per qualcuno – ma efficacissimo per qualcun altro, per lo stesso punto di forza e motivo.”
“L’Irlanda che pesta e che pesta alla grande trova ben più di uno sfogo o di un divertissement in “The Malign Covenant”, titolo azzeccatissimo per una prima prova in studio programmatica di un mo(n)do intero di intendere la materia Black Metal: sulfurea, caliginosa, occulta e spietatamente oscurantista. Non c’è salvezza qui – ma i tre irlandesi ci sorprendono con qualcosa che non è il punto d’incontro dei rispettivi progetti, né una variazione sul tema dell’abbandonato one-off Blood Revolt di oltre dieci anni or sono. Alan non canta da Alan, Matt Bree suona più primitivo, ossessivo e al medesimo tempo ipnotico possibile, e l’ex-Myrkr Joseph Deegan trova una nuova via per esprimere il bisogno di oscurità che non sia costantemente inerpicato sulle dissonanze. Il risultato è stregonesco, pestilenziale e mefitico. Forse monotono per qualcuno – ma efficacissimo per qualcun altro, per lo stesso punto di forza e motivo.”
![]() “Che succede quando tre brillanti e navigati musicisti irlandesi perennemente affascinati dagli occultismi di Necromantia, Cultes Des Ghoules e Mortuary Drape decidono di imbracciare gli strumenti e darne la loro personale interpretazione? Tenendo saggiamente da parte le recenti declinazioni d’oltreoceano di quell’universo maligno, invero più tendenti alla snellezza NWOBHM, e puntando invece su una bestialità diametralmente spuria e grezza, le partiture dei Verminous Serpent si fanno ipnotiche e cacofoniche nel loro incedere. L’affascinante patina di fuliggine e religiosità corrotta tipica dell’Irlanda, ben rappresentata dalla splendida incisione scelta dal trio per presentare la copertina di “The Malign Covenant”, è la chiave per godere di un’uscita che, a dispetto di una tracklist nel complesso priva di forti scossoni e di un potenziale qui parzialmente inespresso da parte dell’ugola di Alan Averill, costruisce un suono nondimeno dal grande appeal, particolarmente efficace sui rallentamenti dalle sinistre sfumature sulfuree che faranno la felicità degli affezionati al più paludoso dei Black Metal.”
“Che succede quando tre brillanti e navigati musicisti irlandesi perennemente affascinati dagli occultismi di Necromantia, Cultes Des Ghoules e Mortuary Drape decidono di imbracciare gli strumenti e darne la loro personale interpretazione? Tenendo saggiamente da parte le recenti declinazioni d’oltreoceano di quell’universo maligno, invero più tendenti alla snellezza NWOBHM, e puntando invece su una bestialità diametralmente spuria e grezza, le partiture dei Verminous Serpent si fanno ipnotiche e cacofoniche nel loro incedere. L’affascinante patina di fuliggine e religiosità corrotta tipica dell’Irlanda, ben rappresentata dalla splendida incisione scelta dal trio per presentare la copertina di “The Malign Covenant”, è la chiave per godere di un’uscita che, a dispetto di una tracklist nel complesso priva di forti scossoni e di un potenziale qui parzialmente inespresso da parte dell’ugola di Alan Averill, costruisce un suono nondimeno dal grande appeal, particolarmente efficace sui rallentamenti dalle sinistre sfumature sulfuree che faranno la felicità degli affezionati al più paludoso dei Black Metal.”
![]() “Sporco, fuligginoso, spaventosamente pesante: gli aggettivi per un debutto di gran carattere come “The Malign Covenant” sono numerosissimi, mentre al contrario pochi ce ne sono di adatti a descrivere un talento che, di riffa o di raffa, finisce sempre col reinventarsi e mantenere alto l’interesse attorno alla totalità delle uscite da esso firmate. Senza affatto trascurare gli sforzi compiuti con l’altrettanto valido progetto Dread Sovereign, il buon Alan Averill ed i suoi nuovi compagni di viaggio ne passano con carta vetrata il megalitico Doom sound rendendolo sgradevole al tatto e all’udito, proprio come dovrebbe essere la musica estrema (nella fattispecie, un Black Metal cadenzato e dalle squisite frequenze basse preminenti) secondo la visione del leader altrove noto come Nemtheanga; il quale si concede il ruolo d’indiscusso protagonista nel mixing di voce e quattro corde, ed al contempo sfrutta i decenni di esperienza da capobanda nei Primordial per far brillare di luce nerissima il pregevole lavoro dei compari così come ognuna delle cinque composizioni.”
“Sporco, fuligginoso, spaventosamente pesante: gli aggettivi per un debutto di gran carattere come “The Malign Covenant” sono numerosissimi, mentre al contrario pochi ce ne sono di adatti a descrivere un talento che, di riffa o di raffa, finisce sempre col reinventarsi e mantenere alto l’interesse attorno alla totalità delle uscite da esso firmate. Senza affatto trascurare gli sforzi compiuti con l’altrettanto valido progetto Dread Sovereign, il buon Alan Averill ed i suoi nuovi compagni di viaggio ne passano con carta vetrata il megalitico Doom sound rendendolo sgradevole al tatto e all’udito, proprio come dovrebbe essere la musica estrema (nella fattispecie, un Black Metal cadenzato e dalle squisite frequenze basse preminenti) secondo la visione del leader altrove noto come Nemtheanga; il quale si concede il ruolo d’indiscusso protagonista nel mixing di voce e quattro corde, ed al contempo sfrutta i decenni di esperienza da capobanda nei Primordial per far brillare di luce nerissima il pregevole lavoro dei compari così come ognuna delle cinque composizioni.”
 Il ritorno più inatteso tra tutti gli impossibili ritorni inaspettati. Proprio per questo, un album come “Vultus Fati” dei Blaze Of Sorrow è oltremodo gradito: perché li avevamo amati con “Eterno Tramonto” (2011), adorati con “Echi” (2012), proposti come una delle migliori realtà italiane mai trovate nel genere e fatti suonare all’unica edizione del nostro festival (2014). Poi, persi nei tre infelici dischi successivi. Ma “Vultus Fati” è diverso. Finalmente diverso.
Il ritorno più inatteso tra tutti gli impossibili ritorni inaspettati. Proprio per questo, un album come “Vultus Fati” dei Blaze Of Sorrow è oltremodo gradito: perché li avevamo amati con “Eterno Tramonto” (2011), adorati con “Echi” (2012), proposti come una delle migliori realtà italiane mai trovate nel genere e fatti suonare all’unica edizione del nostro festival (2014). Poi, persi nei tre infelici dischi successivi. Ma “Vultus Fati” è diverso. Finalmente diverso.
![]() “Ritrovando quel soffio vitale che da un po’ troppo tempo sembrava mancare e ardendo di vigore impetuoso come quello di una fiamma, i Blaze Of Sorrow riescono ad afferrare uno stile che esalta le peculiarità della loro atmosfera, caratterizzandola con una buona dose di dinamismo e un suono più caldo che mai, il quale ne mantiene intatta tutta la ritrovata magia crepuscolare. Tra ricercate sezioni acustiche che si impreziosiscono di una poliedricità elegante di scuola Empyrium anche grazie all’apporto di un’inedita viola, integrata saggiamente nella composizione e non relegata a semplice complemento, e delle vocals gridate al vento con la convinzione e la grande espressività che caratterizzavano il precedentemente irripetuto “Echi”, i mantovani trovano finalmente con “Vultus Fati” la loro dimensione artistica: un’opera ricca, sfaccettata e dal sapore antico, che va a stagliarsi come una delle più mature e solide della loro intera carriera.”
“Ritrovando quel soffio vitale che da un po’ troppo tempo sembrava mancare e ardendo di vigore impetuoso come quello di una fiamma, i Blaze Of Sorrow riescono ad afferrare uno stile che esalta le peculiarità della loro atmosfera, caratterizzandola con una buona dose di dinamismo e un suono più caldo che mai, il quale ne mantiene intatta tutta la ritrovata magia crepuscolare. Tra ricercate sezioni acustiche che si impreziosiscono di una poliedricità elegante di scuola Empyrium anche grazie all’apporto di un’inedita viola, integrata saggiamente nella composizione e non relegata a semplice complemento, e delle vocals gridate al vento con la convinzione e la grande espressività che caratterizzavano il precedentemente irripetuto “Echi”, i mantovani trovano finalmente con “Vultus Fati” la loro dimensione artistica: un’opera ricca, sfaccettata e dal sapore antico, che va a stagliarsi come una delle più mature e solide della loro intera carriera.”
![]() “Dopo una serie di pubblicazioni non esattamente in linea con il mio gusto musicale, l’ultima fatica dei Blaze Of Sorrow mi riporta con piacere e sorpresa al periodo del fortunato “Echi” andando a riprenderne alcune caratteristiche e tratti stilistici, riprendendo un discorso per certi versi interrotto e così facendo rinnovandolo verso nuovi lidi. Durante il corso di “Vultus Fati” veniamo ad esempio travolti da un sound concreto e massiccio accostato a tanto delicati quanto affascinanti richiami folkloristici: già le cavalcate sonore e le scelte compositive dell’opener “Furor” vanno a richiamare il periodo d’oro del Black Metal squisitamente italiano e sono dunque pura gioia all’ascolto, ma anche la scelta delle produzioni nella sintesi dei vari strumenti è eccellente e il tutto suona molto organico e viscerale, senza mai andare a perdere quel tocco di atmosfera e innata epicità che contraddistinguono nel profondo questo tipo di composizioni.”
“Dopo una serie di pubblicazioni non esattamente in linea con il mio gusto musicale, l’ultima fatica dei Blaze Of Sorrow mi riporta con piacere e sorpresa al periodo del fortunato “Echi” andando a riprenderne alcune caratteristiche e tratti stilistici, riprendendo un discorso per certi versi interrotto e così facendo rinnovandolo verso nuovi lidi. Durante il corso di “Vultus Fati” veniamo ad esempio travolti da un sound concreto e massiccio accostato a tanto delicati quanto affascinanti richiami folkloristici: già le cavalcate sonore e le scelte compositive dell’opener “Furor” vanno a richiamare il periodo d’oro del Black Metal squisitamente italiano e sono dunque pura gioia all’ascolto, ma anche la scelta delle produzioni nella sintesi dei vari strumenti è eccellente e il tutto suona molto organico e viscerale, senza mai andare a perdere quel tocco di atmosfera e innata epicità che contraddistinguono nel profondo questo tipo di composizioni.”
Tempo di chiudere con coloro che non ce l’hanno fatta per un misero pelo, coloro con i quali insomma il cosiddetto final-cut questa volta è stato più crudele che con altri. Si parte con i più grossi esclusi, gli Entropia di “Total” (Agonia Records), che faranno la gioia dei più sperimentatori, svirgolati ed allucinati tra chi ci segue oltre a fare il paio coi vichinghi dell’Hordaland (essendo tornati sugli eccellenti livelli del grande ed indimenticato gioiello intitolato “Ufonaut” nel 2016); si prosegue con quei Neo Inferno 262, forse più interessanti sulla carta che non nella pratica ma che meritano sicuramente qualche giro di giostra antiumanitaria e distopica soprattutto tra i più aficionados del verbo Mysticum (e Blacklodge, e Diabolicum, e Diapsiquir…), i quali -se le voci che circolano son vere- comprendono brutti ceffi del satanismo psicoattivo francese con anche qualcuno tra gli autori di “T/Me (3rd Level Initiation = Chamber Of Downfall)” e “Solarkult”, oltre che dei nostri adorati Hell Militia (ahem! “Hollow Void”, prego!) e dei recentemente acclamati Seth (di cui qui si venera ancora “Les Blessures De L’Âme”, e però in realtà davvero poco altro).
Se invece avete già gli occhi s’un mese di aprile che sembra voler essere ancora più ricco di marzo… Sappiate che avete ragione, e che oltre a ciò che avete presumibilmente adocchiato (o insieme ad esso) vi aspettano cose come -in ordine di apparizione- Sól Án Varma, Dødheimsgard, Blodtår, Argenthorns ed Austere… Non ci si può esattamente lamentare, no?
– Matteo “Theo” Damiani –